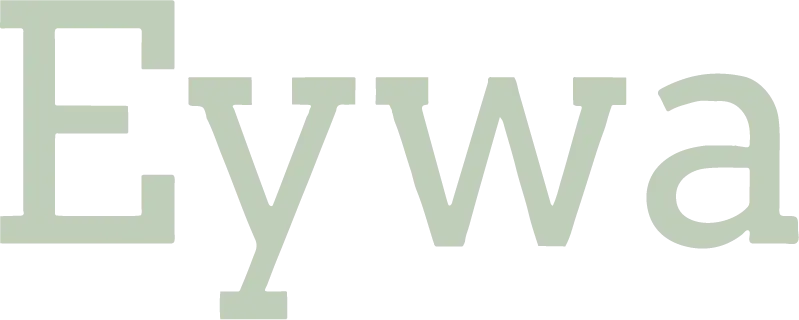Dalle serre verticali all’agricoltura urbana, ecco come natura e tecnologia cambieranno il volto delle città sostenibili
Due scenari e due città, in due momenti diversi nel tempo. La prima immagine è di una Singapore ai giorni nostri, un po’ idealizzata ma del tutto plausibile. La seconda ci proietta in una Milano del 2040, una visione ideale di una metropoli completamente integrata con la natura.
Attraverso i due racconti immaginari capiremo come gli orti verticali, le serre urbane e un design biofilico possano trasformare la vita in città. Ma prima di iniziare, chiariamo il contesto: lo scenario iniziale di Singapore è un presente immaginato ma già possibile oggi, grazie alle tecnologie e le strutture esistenti in città; il racconto ambientato a Milano è invece uno scenario futuristico e ipotetico.
Preparati dunque a camminare tra giardini pensili, respirare aria profumata e scoprire un futuro sostenibile, e un po’ poetico, per le nostre città.
Singapore sostenibile: un presente verde che ispira il futuro
Nell’alba di una Singapore insolitamente quieta, Mei-Lin apre gli occhi. Dalla finestra aperta entra il canto di uccelli nascosti tra le fronde dei giardini verticali sulle facciate dei grattacieli, non il rumore del traffico. Esce di casa e, camminando verso la metropolitana, passa accanto a un rigoglioso orto verticale di quartiere – un piccolo giardino coltivato in altezza su una parete condominiale. Da queste cassette e pannelli verticali sporgono basilico, fragole e menta, bagnati dalla rugiada del mattino e accessibili ai residenti. Far crescere un orto verticale significa proprio questo: sfruttare le pareti degli edifici per far crescere piante e ortaggi in verticale, spesso usando sistemi di irrigazione goccia a goccia e colture idroponiche (tecniche in cui le piante crescono senza terra, con radici immerse in acqua ricca di nutrienti). Il risultato è che anche in pieno centro urbano ci sono muri verdi e piccole oasi commestibili alla portata di tutti.
L’aria ha un profumo diverso dal classico contesto cittadino: si avverte l’odore rinfrescante delle foglie bagnate e il morbido olezzo di fiori tropicali. Merito dell’uso diffuso del design biofilico nell’architettura all’intorno. Il biophilic design (la progettazione biofilica, cioè orientata a coltivare il legame profondo tra esseri umani e natura) è quell’approccio che integra la natura negli edifici – facciate ricoperte di piante, atri con giardini interni, tetti verdi – per riconnettere le persone con l’ambiente naturale. Questa scelta non è solo estetica: vivere quotidianamente a contatto con il verde urbano riduce i livelli di stress e regola la pressione sanguigna secondo numerosi studi. Singapore, già nota come la “città giardino”, da anni investe su queste soluzioni.
Mei-Lin attraversa un ponte pedonale ombreggiato da rampicanti e alberi nani potati con cura – un corridoio verde sospeso che collega il suo quartiere alla stazione. Attorno a lei, architetture avveniristiche e natura convivono in armonia, facendole dimenticare di trovarsi in una metropoli di milioni di abitanti.
Strutture iconiche come i Supertree Grove nei giardini di Singapore (immortalati nella foto incarnano alla perfezione la fusione tra città e natura. Questi giganteschi alberi artificiali, alti decine di metri, ospitano sulle loro armature di acciaio migliaia di piante tropicali. Di giorno offrono ombra e verde, di notte si illuminano come lanterne futuristiche. I Supertree e i tanti giardini pensili della città creano un ecosistema urbano verticale, dando ai cittadini spazi di bellezza e aria pulita anche nel cuore dell’abitato.

Mei-Lin prende la metropolitana automatica diretta al lavoro. La stazione, anziché sbucare su strade caotiche, è immersa in un parco sopra il tetto di un centro commerciale: attorno alle uscite si estendono prati e pergolati in fiore. Questa Singapore immaginata – ma assai vicina alla realtà – è il risultato di alcune scelte visionarie: dai boschi verticali di hotel e condomini lussureggianti, alle serre urbane sperimentali dove si coltiva cibo a chilometro zero sopra i tetti. Prima di entrare in ufficio, Mei-Lin si ferma ad un chiosco che serve smoothie fatti espressi con la frutta coltivata in città: papaie e fragole maturate non in campagna, ma in una serra high-tech a pochi isolati di distanza. In questa metropoli verde, tecnologia e natura si intrecciano in ogni gesto quotidiano, rendendo la vita più dolce e sostenibile.
Milano 2040: la città che respira con il verde urbano
Facciamo un salto in avanti di quindici anni e spostiamoci in Italia. È una mattina di primavera del 2040 e Milano si è trasformata in una città che assomiglia molto alla Singapore sognata di Mei-Lin. Marta, svegliata di buon’ora, apre la porta di casa in un quartiere che un tempo era soffocato dallo smog e dal traffico. Ora la via è pedonale e alberata: filari di alberi da frutto e aiuole aromatiche seguono il tracciato di un ex viale congestionato. Marta richiama a sé i bambini – Elisa, Giulia e Antonio, i suoi figli – devono prepararsi per andare a scuola. Attraversano insieme un piccolo bosco urbano che ha preso il posto di un vecchio parcheggio: il cinguettio degli uccellini copre rumori ovattati e lontani di auto (ormai comunque elettriche e molto silenziose) e l’aria del mattino profuma di muschio e resina, come dopo una pioggia in montagna.
Lungo il percorso passano accanto ad una serra verticale di quartiere, una struttura di più piani completamente dedicata a coltivare ortaggi e verdure per la comunità locale. Giulia indica entusiasta l’ultimo piano dell’edificio, dove intravede file di piante verdi dietro ampie vetrate: è lì che crescono le lattughe, i pomodori e il basilico per la mensa della scuola. Marta approfitta di una breve sosta al mercato vicino alla serra verticale per acquistare qualche alimento: uova fresche deposte sul tetto (dove c’è un piccolo pollaio urbano) e pomodori rossi appena colti in serra. Mentre paga tramite un’app, riceve una notifica: il sistema centrale di gestione predittiva con AI della città segnala che nel pomeriggio potrebbe piovere e consiglia ai cittadini di approfittare delle ultime ore di tempo asciutto per muoversi a piedi o in bici, prima che arrivi la pioggia – piccoli suggerimenti quotidiani che ottimizzano la vita urbana. L’intelligenza artificiale monitora costantemente variabili come meteo, qualità dell’aria e flusso delle persone, prevedendo i bisogni: ad esempio ha già regolato l’irrigazione automatica dei parchi per adattarsi alla pioggia in arrivo, evitando sprechi d’acqua. In questo 2040, la tecnologia lavora dietro le quinte per garantire comfort e sostenibilità, quasi senza che ce ne accorgiamo.
Uno sguardo all’interno di una moderna serra verticale urbana: come si vede in questa immagine [allego immagine], le colture si sviluppano su più livelli sovrapposti, in scaffalature verticali che massimizzano lo spazio disponibile.
Qui le piante non crescono nel terreno, ma secondo la tecnica dell’idroponica: le radici sono immerse in una soluzione acquosa arricchita con elementi nutritivi come azoto, fosforo, potassio, calcio e magnesio, cioè gli stessi nutrienti fondamentali che le piante assorbirebbero normalmente dal suolo, ma in forma direttamente disponibile.
Può sembrare paradossale, ma questo sistema consente di risparmiare fino al 95% di acqua rispetto all’agricoltura convenzionale: infatti, l’acqua che non viene assorbita è recuperata e riutilizzata in un circuito chiuso, senza dispersione nel terreno né evaporazione eccessiva. Inoltre, l’irrigazione è calibrata al millilitro grazie a sensori e centraline digitali, che regolano luce, temperatura, umidità e composizione dei nutrienti in base al ciclo vitale di ciascuna pianta. Il risultato? Raccolti abbondanti, tutto l’anno, senza l’uso di pesticidi chimici e senza dipendere dal clima esterno..
Arrivati a scuola, i bambini corrono verso un ingresso avvolto nel verde: pareti vive coperte di edera e felci li accolgono come un giardino segreto. Nell’atrio, un piccolo parco interno con una fontana purifica e rinfresca l’aria. Marta saluta Elisa, Giulia e Antonio sapendo che passeranno la giornata in ambienti sani: aule luminose piene di piante, orti didattici sul tetto dove imparano a coltivare l’insalata, e persino un sistema di ventilazione naturale progettato per far circolare costantemente aria pulita dall’esterno. Sulla via del ritorno, Marta riflette su quanto sia cambiata la città rispetto alla sua infanzia: le estati afose, trascorse tra calura stagnante e distese di asfalto bollente, hanno lasciato spazio a giardini verticali ovunque che mitigano il clima urbano, attenuando il calore e trasformando il paesaggio. I muri ciechi dei palazzi ora brulicano di vita vegetale; ogni quartiere ha il suo parco o boschetto, e tetti un tempo inutilizzati producono cibo, frescura d’estate e isolamento termico d’inverno, per tutta la comunità. Milano è diventata una “città foresta” dove il confine tra costruito e naturale si fa sempre più sottile. Questa visione del 2040 è di una cosiddetta metropoli bio-integrata: la città diventa un organismo vivente in simbiosi con piante, alberi e persino animali (dalle api impollinatrici nei parchi ai pesci negli specchi d’acqua filtranti delle piazze).
Le città di oggi tra asfalto, smog e pochi alberi: perché le nostre città non respirano ancora?

Le immagini bio-integrate di Singapore e Milano mettono in luce un forte contrasto con la realtà attuale delle nostre grandi città. Oggi, nella Milano reale del 2025, il verde urbano rimane un privilegio di pochi. Solo alcuni quartieri godono di parchi centrali curati, alberi che ombreggiano viali residenziali benestanti o progetti simbolici come il Bosco Verticale di Porta Nuova. Altrove, la città resta dominata da cemento e asfalto, con spazi verdi ancora troppo rari. Per la maggior parte dei cittadini, soprattutto in periferia, il panorama quotidiano è fatto di palazzi grigi, strade congestionate e pochissimo verde. L’aria raramente è “fresca e profumata” come nelle scene sopra descritte: più spesso l’odore opprimente di smog, di carburante e polveri sottili. A Milano, ad esempio, ogni abitante dispone in media di appena 17,8 m² di verde urbano, ben al di sotto della media nazionale (circa 32,8 m²). Non sorprende che ogni inverno si ripresentino allarmi per l’inquinamento atmosferico: senza vento né pioggia, una cappa di smog ristagna tra gli edifici, costringendo a limitazioni del traffico e tenendo i cittadini lontani dall’aria aperta. Il rumore è un altro compagno costante: clacson, motori, sirene – un sottofondo quotidiano di caos sonoro che contrasta nettamente col silenzio verde immaginato nei nostri scenari. Le nostre città assomigliano ancora poco a quei paradisi biofilici sognati: il verde pubblico è scarso e spesso mal distribuito, e vivere in città significa ancora accettare aria insalubre e stress da traffico.
Dalle parole ai progetti: costruire davvero città che respirano
Come passare, dunque, dal caos odierno alle città giardino del futuro? La visione presentata nel racconto di Milano 2040 non è una fantasia irrealizzabile, ma un obiettivo ispirazionale verso cui tendere con le giuste politiche e tecnologie. Le soluzioni tecniche esistono già in nuce: l’agricoltura verticale sta facendo passi da gigante, dimostrando di poter produrre cibo con 98% di suolo in meno e 95% di acqua in meno rispetto all’agricoltura tradizionale, e senza ricorrere a pesticidi. Il design biofilico viene applicato in architettura per migliorare il benessere degli abitanti e l’efficienza energetica degli edifici (pareti verdi e tetti vegetati isolano dal caldo e dal freddo in modo naturale). Le intelligenze artificiali e i sistemi di IoT urbano – la rete di sensori intelligenti che monitora e ottimizza in tempo reale il funzionamento della città – già oggi permettono di monitorare traffico, qualità dell’aria, consumi idrici ed elettrici, aprendo la strada a una gestione predittiva sempre più puntuale della città: pensiamo a semafori intelligenti che regolano il traffico riducendo lo smog, o a reti di irrigazione che si attivano solo quando e dove serve davvero. E poi, una maggiore sensibilità pubblica verso la sostenibilità sta spingendo le amministrazioni a piantare alberi, creare parchi e incentivare la mobilità dolce.
Immaginare città bio-integrate serve a tracciare la rotta. Come nei casi di Mei-Lin e Marta, possiamo guardare a un futuro in cui passeggiare in centro sarà simile ad attraversare un giardino; in cui le scuole avranno serre e orti; i tetti produrranno cibo e l’aria cittadina sarà respirabile e ricca di profumi naturali. Quel futuro potrebbe diventare realtà nel 2040, se investiamo già da oggi in questa direzione. Singapore insegna che trasformare una città non significa stravolgerla, ma ripensarla pezzo per pezzo: un tetto coltivato, una parete verde, un progetto che diventa sistema. Le città bio-integrate saranno forse il risultato più bello di tecnologia e natura che lavorano insieme – luoghi in cui la vita urbana e la vita vegetale si sostengono a vicenda, regalando a chi le abita un’esperienza quotidiana più sana, armoniosa e anche poetica.
FONTI AGRITECTURE, “Vertical farming should be about much more than just yield”, in Agritecture.com, 15 maggio 2018, https://www.agritecture.com/blog/2018/5/15/vertical-farming-should-be-about-much-more-than-just-yield STELLAR Market Research, “Vertical Farming Market”, in stellarmr.com, https://www.stellarmr.com/report/Vertical-Farming-Market/130 URBANFILE, “Milano. Verde in città: solo 17m² di verde urbano a persona”, in urbanfile.org, 8 gennaio 2020, https://blog.urbanfile.org/2020/01/08/milano-verde-in-citta-solo-17m%C2%B2-di-verde-urbano-a-persona/ OECD, “Cities for 2030: Without nature, no sustainable future”, in oecd.org, 13 ottobre 2022, https://www.oecd.org/environment/cities-for-2030-without-nature-no-sustainable-future.htm FAO, “Urban and peri-urban agriculture”, in fao.org, https://www.fao.org/urban-agriculture/en/ EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (EEA), “Urban green infrastructure in Europe: key challenges and opportunities”, in eea.europa.eu, marzo 2021, https://www.eea.europa.eu/publications/urban-green-infrastructure-in-europe