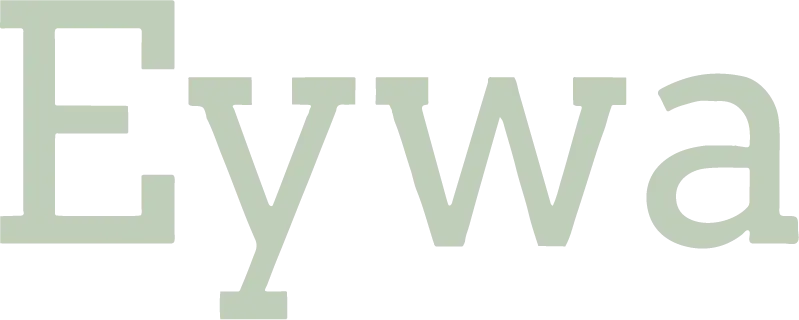ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI EYWA DIVULGAZIONE
Il machine learning è una di quelle rivoluzioni silenziose che, senza far troppo rumore, ha già cominciato a riscrivere il nostro rapporto con la tecnologia. Siamo abituati a pensare ai computer come strumenti che seguono istruzioni dettagliate: ma cosa accade quando iniziano a imparare da soli, osservando, sperimentando, migliorando? In queste pagine ti accompagneremo alla scoperta del cuore pulsante di questa trasformazione. Capiremo insieme cos’è davvero il machine learning, come funziona, quali logiche lo guidano e perché sta diventando sempre più centrale in ambiti che vanno dalla medicina alla finanza, dal linguaggio alle immagini. La sua forza sta proprio qui: non chiede più alla macchina di eseguire, ma di apprendere. Ed è in questo scarto che si apre un mondo nuovo.
L’espressione “machine learning” compare per la prima volta nel 1959, per mano di Arthur Samuel, pioniere dell’intelligenza artificiale ai laboratori IBM. Fu lui a definirlo come il campo di studio che offre ai computer la capacità di imparare, senza che ogni azione venga programmata a mano. All’epoca si parlava anche di “computer autodidatti”: una formula che, a ben vedere, anticipava l’orizzonte attuale con sorprendente lucidità.

Il primo modello pratico di apprendimento automatico risale proprio a quegli anni, quando Samuel sviluppò un programma capace di calcolare le probabilità di vittoria nel gioco della dama, adattando le mosse in base all’esperienza. Ma le radici teoriche di questa tecnologia vanno ancora più a fondo: bisogna risalire agli studi sui meccanismi dell’intelligenza umana. Già nel 1949, lo psicologo canadese Donald Hebb proponeva una teoria affascinante nel suo libro The Organization of Behavior: le cellule nervose, interagendo tra loro, rafforzano i legami con l’uso. Un’intuizione che ha ispirato la struttura degli algoritmi moderni, basati su nodi artificiali che si scambiano informazioni in modo simile a quanto avviene nel nostro cervello.
Una definizione più formale — oggi spesso citata — è quella del ricercatore Tom Mitchell. Nel 1997 scriveva: “Un programma informatico apprende dall’esperienza E rispetto a una classe di compiti T e una misura di prestazione P, se le sue prestazioni nei compiti in T, misurate da P, migliorano con l’esperienza E”. È un modo chiaro e concreto per capire di cosa si tratta: non tanto un processo mentale, quanto una capacità di migliorare nel fare, attraverso l’esperienza. Una prospettiva in linea con quanto suggeriva Alan Turing, che preferiva porsi una domanda diversa da quella classica: “Le macchine possono pensare?”. Meglio chiedersi, piuttosto: “Le macchine possono fare ciò che facciamo noi, in quanto esseri pensanti?”.
Il machine learning è una parte specifica dell’intelligenza artificiale, e ne condivide gli obiettivi più ambiziosi. Come si dice spesso nel settore, “tutto il machine learning è intelligenza artificiale, ma non tutta l’intelligenza artificiale è machine learning”. Il cuore della questione è che, anziché scrivere ogni istruzione necessaria, si offre alla macchina l’opportunità di imparare da sola, grazie all’analisi dei dati.
È proprio qui che il machine learning si distingue dai sistemi informatici tradizionali. Invece di seguire sequenze di comandi preimpostati, questi algoritmi sono progettati per individuare pattern nei dati e sfruttarli per fare previsioni o prendere decisioni. Nessun bisogno di intervento umano diretto, né di infinite righe di codice: bastano i dati, e un sistema capace di adattarsi. Un approccio potente, soprattutto di fronte a problemi complessi o variabili, dove le regole fisse non sono più sufficienti.
Come funziona il Machine Learning
fondamentali: i dati, i software e l’hardware. È dalla loro combinazione che nascono i modelli predittivi capaci di interpretare la realtà, anticipare scenari o prendere decisioni autonome. Gli algoritmi di machine learning non si limitano a replicare formule o seguire regole preimpostate: imparano direttamente dai dati, usando strumenti matematici e computazionali per costruire una propria “conoscenza del mondo”, senza bisogno di equazioni fisse o modelli già scritti.
Un punto importante — spesso fonte di confusione — è la distinzione tra algoritmo e modello. L’algoritmo è come una ricetta: un insieme di istruzioni su come apprendere dai dati. Il modello, invece, è il piatto finito. In pratica, quando applichiamo un algoritmo a un set di dati, ciò che otteniamo alla fine del processo di apprendimento è un modello, cioè qualcosa che può essere usato per fare previsioni o prendere decisioni su nuovi dati mai visti prima. Prima dell’addestramento c’è un metodo; dopo, c’è un sapere applicabile.
Il Processo di apprendimento
Il modo in cui apprende un sistema di machine learning non è poi così distante da come apprendiamo noi esseri umani. Pensiamo, per esempio, a un bambino che sta imparando a riconoscere i cani. La prima volta che ne incontra uno — magari un cucciolo dal muso buffo e le orecchie morbide — associa quell’animale a un insieme di caratteristiche: la coda che scodinzola, il naso umido, il suono del latrato. Se quell’esperienza è piacevole, lascia un segno nella memoria. E così, la volta successiva, anche se il cane che ha davanti è diverso per razza, taglia o colore, il bambino riesce comunque a riconoscerlo come un cane, grazie a quelle somiglianze.

Il machine learning funziona più o meno allo stesso modo. L’algoritmo osserva una serie di esempi — i dati di addestramento — e impara a cogliere schemi, somiglianze, relazioni. Una volta “allenato”, è in grado di affrontare dati mai visti prima, applicando ciò che ha appreso per formulare previsioni o prendere decisioni. In altre parole: impara dall’esperienza, e usa quell’esperienza per orientarsi nel nuovo.
Addestramento e test
Per costruire un buon modello di machine learning, serve un processo ben collaudato, che inizia quasi sempre con una semplice divisione: i dati a disposizione vengono separati in due gruppi. Uno servirà per l’addestramento (training set), l’altro per il test (testing set). È come insegnare qualcosa a un allievo e poi verificare se ha davvero capito. Nella prima fase, il modello analizza il training set per individuare relazioni tra le informazioni in ingresso e i risultati attesi. Nella seconda fase, si testa ciò che ha imparato, usando dati che non ha mai visto prima, per capire se riesce a generalizzare, cioè a comportarsi bene anche fuori dal “copione”.
Un esempio concreto può rendere tutto più chiaro. Supponiamo di voler creare un modello capace di prevedere il prezzo delle case in una città. Raccogliamo allora un insieme di dati reali: la superficie dell’immobile, il numero di stanze, la presenza o meno di un giardino, eventuali servizi aggiuntivi e, naturalmente, il prezzo di vendita. A questo punto dividiamo il dataset: una parte (diciamo l’80%) andrà nel training set, il resto nel testing set.
Durante l’addestramento, il modello impara a riconoscere le connessioni tra le caratteristiche delle case e il loro prezzo. Una volta terminata questa fase, lo mettiamo alla prova con il testing set. Gli forniamo solo le informazioni sulle case, senza i prezzi, e gli chiediamo di prevederli. Poi confrontiamo le sue previsioni con i prezzi reali. Se si avvicina molto, significa che ha imparato bene; se sbaglia spesso, vuol dire che c’è ancora da lavorare. È così che si misura la sua affidabilità.
Apprendimento supervisionato
L’apprendimento supervisionato funziona un po’ come in una classe di scuola. Immaginiamo un insegnante che mostra ai bambini come si scrive la lettera “A”: la disegna alla lavagna, lentamente, con cura. I bambini osservano, provano a imitarla. All’inizio commettono errori, ma con il tempo imparano. Finché, un giorno, riescono a scriverla da soli, senza più bisogno della guida dell’insegnante.
Allo stesso modo, un sistema di machine learning supervisionato viene addestrato su dati etichettati, cioè su informazioni che includono già la risposta corretta per ogni esempio. La macchina osserva questi esempi, apprende le relazioni tra i dati e costruisce un modello che, una volta addestrato, può essere applicato a nuovi casi mai visti prima.
All’interno dell’apprendimento supervisionato esistono due grandi categorie operative. La prima è la classificazione, che consiste nell’insegnare alla macchina a distinguere tra categorie diverse. È come riempire un cesto di frutta: se il sistema ha imparato a riconoscere mele, pere e fragole grazie a immagini etichettate, potrà poi classificare correttamente nuovi frutti, anche se non li ha mai visti esattamente così.

La seconda categoria è la regressione, che serve a fare previsioni numeriche basate su dati noti. Torniamo all’esempio immobiliare: se forniamo al modello dati su posizione, metratura e numero di stanze, può imparare a stimare il prezzo di una casa, anche se non ne ha mai visto una identica.
Tra gli strumenti più utilizzati in questo tipo di apprendimento troviamo algoritmi come la regressione lineare e logistica, usati per stimare valori numerici o probabilità — ad esempio, quanto è probabile che una persona clicchi su un annuncio pubblicitario. Ci sono poi le macchine a vettori di supporto (SVM), che disegnano confini netti tra categorie, un po’ come se tracciassero linee immaginarie per distinguere mele da pere. Gli alberi decisionali, invece, somigliano a un gioco di domande a risposta multipla: “Ha il pelo? Fa miao? Allora è un gatto”. Le foreste casuali sono gruppi di tanti alberi decisionali che lavorano insieme, come una squadra che vota a maggioranza. E infine ci sono le reti neurali, ispirate al funzionamento del cervello umano, capaci di apprendere in modo flessibile e di adattarsi anche a dati complessi come immagini o suoni.
Ognuno di questi strumenti ha le sue particolarità, ma tutti condividono lo stesso principio: imparare dai dati già etichettati per saper riconoscere, prevedere e decidere in situazioni nuove.
Apprendimento non supervisionato
L’apprendimento non supervisionato è come esplorare una città sconosciuta senza una mappa, ma con un buon senso dell’orientamento. Gli algoritmi, in questo caso, non ricevono indicazioni su quale sia la “risposta giusta”: non ci sono etichette, né istruzioni precise. L’obiettivo è osservare i dati grezzi e scoprire da sé strutture, somiglianze, connessioni nascoste. È un tipo di apprendimento che imita l’intuito naturale con cui anche noi riconosciamo degli schemi nel mondo.
Pensiamo a un bambino che conosce solo il cane di casa. Quando ne vede un altro per la prima volta — magari il barboncino di un visitatore — sorride riconoscendo qualcosa di familiare: le orecchie, la coda, l’abbaiare. Nessuno gli ha spiegato che quello è un cane diverso dal suo, ma il bambino riesce a fare un collegamento spontaneo. È lo stesso principio su cui si basa l’apprendimento non supervisionato.
Una delle tecniche principali in questo ambito è il clustering, ovvero la capacità di raggruppare dati simili tra loro anche se non hanno un’etichetta. È quello che avviene nel marketing quando si suddividono i clienti in gruppi sulla base dei comportamenti d’acquisto: chi compra regolarmente, chi acquista solo in saldo, chi preferisce certi prodotti. Nessuno ha detto all’algoritmo quali sono i gruppi da cercare — li scopre da solo, mettendo insieme i pezzi.
Un’altra tecnica importante è la riduzione della dimensionalità, che consiste nel semplificare i dati eliminando variabili ridondanti, per cogliere l’essenza delle informazioni disponibili. È come guardare una mappa in scala: perdi qualche dettaglio, ma capisci meglio il paesaggio generale.
Questo tipo di apprendimento è particolarmente utile quando si ha a disposizione una grande quantità di dati non etichettati — e si vogliono far emergere strutture invisibili, intuizioni nuove, o nuove domande a cui non si era ancora pensato di rispondere.
Apprendimento per rinforzo
L’apprendimento per rinforzo — in inglese Reinforcement Learning, o più semplicemente RL — è forse il più “istintivo” dei metodi di machine learning. Si basa sull’idea che per imparare a prendere decisioni efficaci servano tanti tentativi, qualche errore e un sistema di premi e punizioni. È un approccio che assomiglia sorprendentemente a come apprendiamo noi esseri umani fin da piccoli: facciamo una cosa, osserviamo le conseguenze, e la ripetiamo solo se ci ha portato a qualcosa di buono.
In questa modalità, un algoritmo non riceve istruzioni dettagliate. Gli si assegna un compito e si lascia che esplori da solo le possibili azioni. Quando fa qualcosa che lo avvicina all’obiettivo, riceve una ricompensa. Quando si allontana, non ottiene nulla — o, in alcuni casi, riceve un segnale negativo. È questo meccanismo di feedback continuo a guidarlo nel tempo verso le decisioni migliori.
Una caratteristica interessante degli algoritmi di reinforcement learning è la capacità di tollerare la gratificazione ritardata. Non sempre la scelta giusta è quella che dà un premio immediato: a volte bisogna “perdere una battaglia per vincere la guerra”. L’algoritmo impara a valutare anche percorsi più lunghi e complessi, che magari includono ostacoli iniziali ma conducono al miglior risultato possibile.
Un esempio concreto? Pensiamo a un robot, o a un veicolo a guida autonoma. Non c’è un manuale che spieghi come affrontare ogni incrocio, ostacolo o deviazione. Ma il sistema, interagendo con l’ambiente, capisce che evitare un muro è meglio che andarci contro, che rallentare in curva è più utile che accelerare. Col tempo, queste decisioni si perfezionano, fino a diventare strategie sofisticate.
Reti Neurali e Deep Learning
Immagina un algoritmo che impara osservando il mondo un po’ come facciamo noi: analizza segnali, coglie schemi, fa previsioni sempre più accurate. È questo il principio alla base delle reti neurali, sistemi informatici ispirati al funzionamento del cervello umano. Quando queste reti vengono costruite in modo particolarmente profondo e stratificato, si parla di deep learning — un’area avanzata del machine learning che sfrutta l’enorme potenza di calcolo moderna per analizzare quantità di dati davvero gigantesche.
Oggi le tecniche di deep learning sono tra le più sofisticate nel riconoscere oggetti in una fotografia o parole in una registrazione audio. Ma il loro potenziale si estende ben oltre: si stanno già applicando alla traduzione automatica, alla diagnosi precoce di malattie e ad altri compiti dove la precisione è vitale.
Una tecnica chiave in questo campo, specialmente quando si lavora con immagini, è quella della convoluzione. Si tratta di un’operazione matematica che “condensa” l’immagine, estraendo le caratteristiche più significative. Nelle reti neurali convoluzionali (o CNN), ogni strato della rete applica dei filtri, come una lente che mette in risalto dettagli diversi. Gli strati iniziali individuano elementi semplici — come contorni, curve, texture — mentre quelli successivi riconoscono strutture sempre più complesse: una testa, un occhio, una coda. Alla fine, la rete costruisce una comprensione profonda dell’immagine.
Ma le reti neurali non sono l’unico strumento. Alcuni algoritmi — come le macchine a vettori di supporto (SVM), gli alberi decisionali e le foreste casuali — sono molto efficaci nel classificare dati. Pensiamo, ad esempio, ai filtri antispam: grazie a questi algoritmi, è possibile riconoscere automaticamente le email indesiderate, sulla base di fattori come mittente, parole chiave o struttura del messaggio.
Un’altra famiglia di strumenti, quelli della regressione, viene invece impiegata per prevedere valori numerici continui. La regressione lineare, per esempio, serve a identificare la relazione tra variabili: come cambia il prezzo di una casa al variare della sua metratura o della zona in cui si trova. Questi modelli vengono usati ogni giorno in ambiti come il mercato immobiliare, l’analisi delle vendite o la previsione del rischio finanziario.
Applicazioni pratiche del Machine Learning
Il machine learning è ormai ovunque. Dai laboratori di ricerca è passato silenziosamente nelle corsie d’ospedale, nei mercati finanziari, nei centri di elaborazione dati e persino tra le righe di documenti scritti a mano. Sta trasformando il modo in cui viviamo, lavoriamo e ci relazioniamo al mondo. Vediamo insieme alcune delle sue applicazioni più significative.
Sanità
Nel campo medico, il machine learning si è rivelato uno strumento potente e prezioso. I sistemi di intelligenza artificiale sono in grado di analizzare con estrema precisione immagini mediche — come risonanze magnetiche, radiografie e TAC — individuando segnali nascosti che potrebbero sfuggire anche all’occhio più esperto, o che un medico affaticato potrebbe trascurare.
Oltre all’imaging (per “imaging” si intende la produzione e l’analisi di immagini mediche, come radiografie, risonanze magnetiche o TAC, utilizzate per osservare l’interno del corpo umano senza interventi invasivi), questi modelli possono mettere insieme una mole impressionante di dati: sintomi, informazioni genetiche, fattori ambientali e stili di vita. Così facendo, suggeriscono diagnosi precoci, come nel caso di patologie complesse quali cancro, diabete o malattie cardiovascolari. Le tecniche di regressione, poi, permettono di stimare il rischio individuale di sviluppare una determinata condizione, offrendo agli operatori sanitari strumenti predittivi per un’assistenza sempre più personalizzata.
Non solo numeri e cartelle cliniche. Con l’analisi del linguaggio naturale e del sentiment, le organizzazioni sanitarie possono anche leggere tra le righe delle conversazioni con i pazienti, cogliendo emozioni, bisogni e malesseri latenti. Un piccolo aiuto tecnologico per costruire un dialogo più umano.
Riconoscimento della scrittura a mano
Un’applicazione affascinante — e per certi versi poetica — è il riconoscimento della scrittura a mano. Si tratta di addestrare i modelli a leggere testi scritti manualmente, un po’ come facciamo noi davanti a un vecchio quaderno.
Questa tecnologia è già usata per digitalizzare archivi storici, decifrare ricette mediche o modulistica compilata a penna. I vantaggi sono enormi: risparmio di tempo, migliore accessibilità, e soprattutto la possibilità di preservare documenti preziosi — lettere, registri, appunti — che altrimenti rischierebbero di perdersi nel tempo.
Previsioni finanziarie
Nel mondo della finanza, dove anche pochi secondi fanno la differenza, il machine learning è diventato uno degli alleati più affidabili. Analizzando dati storici, notizie, indicatori di mercato e comportamenti degli investitori, questi sistemi riescono a prevedere fluttuazioni nei prezzi delle azioni, variazioni nei tassi di cambio e tendenze nei consumi.
Tuttavia, non tutto è semplice come sembra. L’efficacia di questi modelli dipende dalla qualità dei dati: se i dati sono distorti, incompleti o riflettono pregiudizi preesistenti, anche le previsioni saranno inquinate. Inoltre, molti dei modelli più sofisticati — come le reti neurali profonde — sono delle vere e proprie “scatole nere”: funzionano bene, ma non sempre è chiaro perché. E questo solleva domande delicate, specialmente in un settore dove la trasparenza è cruciale.
Etica e Privacy
Ed è qui che il discorso tecnico incontra un nodo morale. L’uso crescente del machine learning ci impone di farci alcune domande fondamentali. Chi ha accesso ai nostri dati? Come vengono usati? Gli algoritmi sono davvero imparziali o rischiano di riprodurre e amplificare le disuguaglianze sociali già esistenti?
La posta in gioco è alta: sorveglianza di massa, violazioni della privacy, discriminazioni automatizzate. Per questo motivo, è essenziale che lo sviluppo e l’implementazione di queste tecnologie avvengano nel rispetto dei diritti umani e dei principi di giustizia ed equità. Il progresso non può essere cieco.
Uno sguardo al futuro
Il machine learning è una delle frontiere più dinamiche e promettenti della tecnologia contemporanea. E siamo solo all’inizio. Stanno già emergendo nuove direzioni, come l’apprendimento federato, che consente di addestrare modelli su dispositivi diversi senza mai centralizzare i dati. Oppure l’apprendimento continuo, che permette ai sistemi di aggiornarsi man mano che ricevono nuove informazioni, senza dimenticare quanto appreso in precedenza.
L’integrazione con altre tecnologie, come la blockchain o l’Internet delle Cose, sta aprendo scenari che fino a pochi anni fa sembravano fantascienza.
Ma come ogni grande potere, anche questo comporta grandi responsabilità. Il vero futuro del machine learning dipenderà da come sapremo governarlo, orientarlo, guidarlo verso usi che mettano al centro la dignità delle persone, l’ambiente, il bene collettivo. Perché i dati parlano, ma sta a noi ascoltare con coscienza.
FONTI
Cloud.it, Introduzione al machine learning, Cloud.it. Disponibile su: https://www.cloud.it/tutorial/introduzione-al-machine-learning.aspx
SAP, Che cos’è il machine learning?, SAP Italia. Disponibile su: https://www.sap.com/italy/products/artificial-intelligence/what-is-machine-learning.html
Hewlett Packard Enterprise, Che cos’è il machine learning?, HPE. Disponibile su: https://www.hpe.com/it/it/what-is/machine-learning.html
Mitchell, T. M. (1997), Machine Learning, Cambridge University Press. Disponibile su: https://www.cambridge.org/core_title/gb/564257
IBM, Supervised Learning, IBM Think. Disponibile su: https://www.ibm.com/think/topics/supervised-learning
Oracle, Apprendimento non supervisionato, Oracle Italia. Disponibile su: https://www.oracle.com/it/artificial-intelligence/machine-learning/unsupervised-learning/
Amazon Web Services (AWS), What is Reinforcement Learning?, AWS. Disponibile su: https://aws.amazon.com/what-is/reinforcement-learning/
Oracle, Che cos’è il machine learning?, Oracle Italia. Disponibile su: https://www.oracle.com/it/artificial-intelligence/machine-learning/what-is-machine-learning/
Mitchell, T. M., Machine Learning, Carnegie Mellon University. Disponibile su: http://www.cs.cmu.edu/~tom/mlbook.html