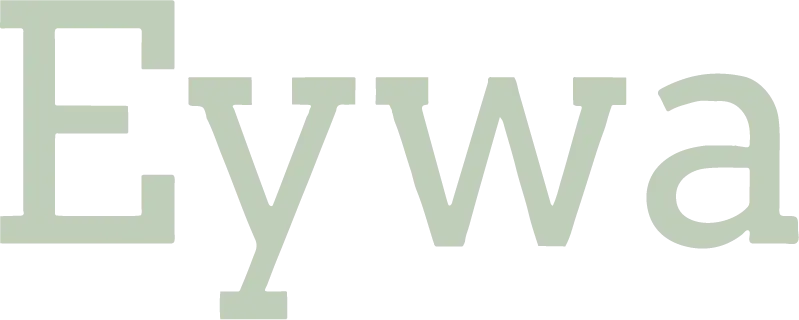Immagina di installare un’app di shopping sul tuo smartphone per approfittare di sconti incredibili. Senza saperlo, però, hai messo in tasca un dispositivo di sorveglianza che osserva ogni tuo movimento. Temu – la piattaforma di e-commerce cinese lanciata nel 2022 – è l’esempio estremo di capitalismo della sorveglianza, dove ogni azione digitale (e non) viene trasformata in dati da sfruttare commercialmente. A differenza di altre app, Temu va ben oltre il monitoraggio dei tuoi acquisti: pare che possa osservare cosa fai sul telefono anche fuori dall’app, seguire la tua posizione tramite GPS e Wi-Fi, persino attivare microfono e fotocamera di nascosto per carpire informazioni ambientali. In pratica, uno spyware travestito da negozio online. Non è fantascienza né teoria del complotto: esperti di cybersecurity hanno avvertito che Temu “si comporta in pratica come uno spyware” e l’hanno definita “l’app più pericolosa in circolazione”. Eppure milioni di persone la scaricano volontariamente, consegnando ai suoi gestori un tesoro di informazioni che farebbe gola a qualsiasi agenzia di intelligence. Vediamo allora perché Temu preoccupa così tanto – dalla raccolta massiccia di dati ai rischi per sicurezza, democrazia e benessere personale – e in cosa differisce dagli altri giganti digitali come Amazon, Meta, Google o Shein.
Chi c’è dietro Temu? Legami nascosti con la Cina
Chi controlla realmente Temu? L’app è di proprietà di PDD Holdings, colosso nato in Cina (originariamente con il nome Pinduoduo) e oggi formalmente registrato alle Isole Cayman. Sebbene Temu dichiari sede legale a Boston (USA) e recentemente PDD abbia spostato il quartier generale a Dublino (Irlanda), le sue radici e gran parte delle operazioni rimangono in Cina. Nei documenti societari stessi PDD ammette che “le attività delle società che possediamo e gestiamo in Cina sono soggette alle leggi e ai regolamenti della RPC” (Repubblica Popolare Cinese). In altre parole, Temu/PDD è vincolata dalla legislazione cinese, inclusa la severa legge sull’intelligence nazionale del 2017 che obbliga qualsiasi organizzazione o cittadino cinese a “supportare e cooperare con il lavoro d’intelligence dello Stato”. Ciò significa che, se richiesto, Temu dovrebbe fornire al governo di Pechino qualunque dato raccolto.
Non solo: una ricerca dell’Australian Strategic Policy Institute (ASPI) ha rivelato che PDD Holdings è partner corporativo di People’s Data Management Co. Ltd, una società statale controllata direttamente dal Partito Comunista Cinese. People’s Data funge da piattaforma attraverso cui aziende e governo condividono Big Data; in pratica è il braccio dati del quotidiano ufficiale del Partito (People’s Daily). Sebbene non sia di dominio pubblico quali informazioni PDD condivida su questa piattaforma, il sospetto è che possano includere anche i dati raccolti da Temu. Del resto, la stessa informativa privacy di Temu avvisa che i dati personali degli utenti “possono essere condivisi con la casa madre, le sussidiarie e affiliate, nonché con autorità di legge e governo” in caso di necessità. Insomma, Temu parla cinese più di quanto ammetta: dietro l’apparente società internazionale si intravedono le ombre di Pechino, con implicazioni inquietanti per la sovranità dei dati degli utenti di tutto il mondo.
Temu come spyware? Funzionalità nascoste e rischi per la sicurezza
Le accuse rivolte a Temu da analisti indipendenti e inchieste giornalistiche sono gravissime: secondo la società di ricerca Grizzly Research, il codice dell’app nasconderebbe funzioni da vero e proprio malware create apposta per rubare una quantità enorme di dati senza che l’utente se ne accorga. In pratica Temu richiede – o ottiene con escamotage – permessi sul telefono che vanno ben oltre il necessario per fare shopping. Ad esempio, sembra che il software sia in grado di: accedere alla lista dei contatti, leggere email e messaggi privati, raccogliere il registro delle chiamate, tracciare la cronologia di navigazione web, e persino modificare impostazioni di sistema. Può sondare le altre app installate, come dicevamo, attivare sensori come microfono, fotocamera, Bluetooth, e geolocalizzazione, il tutto di nascosto e senza consenso informato.
Un normale negozio online ha bisogno dei tuoi dati di pagamento e dell’indirizzo per spedire i prodotti. Temu invece vuole molto di più: vuole tutto quello che è memorizzato o passa per il tuo smartphone.
Queste capacità ricordano sinistramente il comportamento di trojan e spyware governativi. Non a caso, nel 2023 la sua “sister app” Pinduoduo (gestita dallo stesso gruppo) è stata scoperta a sfruttare falle su Android per bypassare le protezioni del telefono, leggere notifiche e messaggi e controllare altre applicazioni. Google l’ha rimossa dal Play Store per questo motivo. Temu in apparenza non è stata sorpresa in flagrante allo stesso modo, ma il sospetto che condivida parte di quel codice malevolo è forte. Tanto che a fine 2023 sono state avviate azioni legali collettive negli USA, accusando Temu di pratiche “ingannevoli e sleali” nel raccogliere dati e di richiedere permessi ingiustificati per un’app di e-commerce (come l’accesso al Wi-Fi, ai dati biometrici, al Bluetooth). In pratica, Temu viene dipinta come un cavallo di Troia digitale: dietro ai prezzi stracciati si nasconderebbe una sorveglianza capillare. Non stupisce quindi che esperti di sicurezza invitino gli utenti alla massima cautela – c’è chi consiglia esplicitamente di disinstallarla immediatamente per proteggere la propria privacy.
Algoritmi che sfruttano le nostre debolezze: prezzi personalizzati e acquisti pilotati
La questione dati non riguarda solo la privacy, ma anche come queste piattaforme li usano contro di noi nelle strategie commerciali. Studi recenti hanno messo in luce una preoccupante tendenza: gli algoritmi discriminano gli utenti in base alle loro vulnerabilità informative o cognitive, sfruttandole a fini di profitto. Il prezzo che paghiamo e i prodotti che vediamo possono dipendere da quanto siamo “sprovveduti” o impulsivi. Alcune app e siti adottano prezzi dinamici differenziati: il costo di un prodotto non è fisso, ma può aumentare per l’utente che appare più facoltoso o meno sensibile al prezzo. Oppure, possono fioccare sconti-lampo per chi esita, così da spingerlo all’acquisto immediato. Altri algoritmi promuovono prodotti di qualità inferiore o meno convenienti a segmenti di pubblico identificati come meno informati o attenti, massimizzando il margine di guadagno a scapito del consumatore ignaro. Quasi tutti sfruttano i nostri bias cognitivi: se sei propenso agli acquisti compulsivi o hai mostrato debolezza per le offerte col conto alla rovescia, l’app te ne servirà a vassoiate. Notifiche push, banner “Ultimi pezzi rimasti!”, sconti personalizzati sul prodotto appena sbirciato – tutto calibrato per far leva sui tuoi punti deboli e indurti a comprare anche ciò di cui non hai bisogno.
Temu e piattaforme simili ci studiano con attenzione inquietante, creando un profilo dettagliato dei nostri comportamenti di consumo. Ogni scroll, clic, tempo di permanenza su un articolo: l’algoritmo impara e si adatta. Lo scopo? Massimizzare il profitto sfruttando ogni falla del nostro raziocinio. Se può sembrare eccessivo, basta pensare a quante volte abbiamo comprato qualcosa perché “era in super offerta per poche ore” o perché altri 100 utenti lo stavano “guardando ora”. Non era un caso: era l’algoritmo che ci teneva in pugno, conoscendo le nostre micro-debolezze. Queste piattaforme instaurano un rapporto asimmetrico: loro sanno tutto di noi, noi non sappiamo nulla dei loro meccanismi. E nell’opacità si insinua una nuova forma di discriminazione commerciale, dove il consumatore vulnerabile paga di più o ottiene di meno.
83 milioni di smartphone a rischio: l’ipotesi di una botnet globale
Oltre alla sfera individuale, Temu solleva preoccupazioni di cybersicurezza nazionale. Negli Stati Uniti l’app ha raggiunto quasi 83 milioni di utenti attivi, una diffusione incredibile in pochissimo tempo. Il dato, di per sé impressionante, fa sorgere uno scenario da brividi: e se tutti quegli smartphone fossero trasformati in una rete zombie al servizio di un attacco informatico? Secondo alcuni analisti, infatti, Temu avrebbe il potenziale tecnico per impiegare i dispositivi infetti come nodi di una gigantesca botnet. Le botnet sono reti invisibili composte da computer e dispositivi inconsapevoli, trasformati in “zombie” da un virus informatico. A guidarli non è il loro proprietario, ma un regista nascosto che li controlla da remoto. Così, macchine di tutto il mondo possono essere usate insieme come un unico strumento di potere: per bloccare siti, rubare dati o diffondere altri virus.
In un ipotetico caso estremo, una volta ottenuti privilegi profondi sul telefono (come quelli che pare si prenda), Temu potrebbe ricevere da remoto comandi malevoli: ad esempio, coordinare milioni di telefoni per lanciare contemporaneamente un attacco hqcker DDoS (Distributed Denial of Service) contro bersagli specifici. 83 milioni di dispositivi contro un singolo obiettivo sensibile – come i server di infrastrutture critiche – significherebbe un’arma informatica senza precedenti, capace di mettere in ginocchio siti governativi, reti elettriche, sistemi finanziari. Finora attacchi del genere si sono visti utilizzando elettrodomestici IoT o PC infetti, anche smartphone, ma mai su scala così ampia. Temu potrebbe aprire questa strada.
Anche tralasciando gli scenari più catastrofici, il solo fatto che un’app di shopping possa avere controllo profondo su decine di milioni di telefoni è allarmante. Significa che in teoria qualcuno – diciamo un governo ostile o un gruppo hacker che compromettesse Temu – potrebbe spegnere o sabotare da remoto tutti quei dispositivi (si pensi alla possibilità di brickare i telefoni, renderli inutilizzabili, con un singolo comando inviato via app). Non parliamo più solo di furto di dati, ma di un potere di interferenza diretta sui dispositivi degli utenti. È per questo che alcuni esperti di sicurezza nazionale equiparano Temu a una potenziale minaccia strategica: non è solo questione di privacy, ma di resilienza delle reti e degli apparati civili di un Paese.
Dipendenza da social e shopping: FOMO, ansia e relazioni in crisi
Sul fronte del benessere personale, l’esposizione prolungata agli ambienti digitali – siano essi social network o app di e-commerce come Temu – può avere conseguenze negative sulla salute mentale. La ricerca psicologica degli ultimi anni parla chiaro: queste piattaforme sfruttano meccanismi di ricompensa variabile (simili a quelli delle slot machine) che possono indurre una vera e propria dipendenza comportamentale. Scorrere all’infinito il feed di prodotti o offerte, aspettare l’ultimo deal giornaliero, collezionare crediti o coupon: ti suona familiare? Sono tutti sistemi pensati per trattenerti il più a lungo possibile e farti tornare spesso, creando assuefazione.
I sintomi di questa dipendenza digitale non sono diversi da altre dipendenze: tolleranza (hai bisogno di passare sempre più tempo sull’app per provare soddisfazione), astinenza (ansia o irritazione quando non puoi controllare offerte e notifiche), craving (desiderio compulsivo di aprire l’app in ogni momento libero). Non a caso, molti studi associano l’uso compulsivo di social media e shopping online a aumentati livelli di ansia e depressione nella popolazione. Un catalizzatore potente di questi comportamenti è la FOMO (Fear of Missing Out, cioè l’ansia di perdere un’occasione, un’informazione o un’esperienza che gli altri stanno vivendo): la paura di perdersi qualcosa. Nel contesto di Temu, può essere la paura che l’affare del secolo scada prima che tu lo colga, o che altri ottengano vantaggi che a te sfuggono. Questa ansia di essere “tagliati fuori” alimenta un utilizzo ancora più frenetico e compulsivo dell’app.
A livello sociale, l’iperconnessione ai mondi digitali va spesso di pari passo con un deterioramento delle relazioni interpersonali autentiche. Ogni ora spesa a caccia di offerte su Temu (o a scorrere Instagram, poco cambia) è un’ora sottratta a interazioni reali: parlare con la famiglia, uscire con gli amici, leggere un libro in tranquillità. Ci ritroviamo invece isolati, seppur virtualmente iper-stimolati, e questo può minare le nostre abilità sociali e l’equilibrio emotivo. Studi segnalano che chi sviluppa dipendenza da attività online mostra spesso maggiore solitudine, minore soddisfazione nelle relazioni e una ridotta capacità di concentrazione. Insomma, quello che in apparenza è solo “shopping innocuo” o svago sui social nasconde un lato oscuro: può succhiare tempo, energie mentali e benessere emotivo, lasciandoci più ansiosi e soli.
Profilazione estrema: dati e potere fuori controllo
Ma come abbiamo visto, l’aspetto cruciale è la profilazione avanzata che piattaforme come Temu (e la citata Shein, nel campo della moda) effettuano sui propri utenti. Ogni clic, ogni preferenza espressa, ogni secondo di permanenza su una pagina contribuisce a costruire un tuo “gemello digitale”, un profilo dettagliatissimo dei tuoi gusti, delle tue abitudini, dei tuoi bisogni, delle tue paure. Questa profilazione iper-accurata rappresenta una minaccia significativa per l’autonomia individuale e persino per la democrazia.
Siamo di fronte a un modello di capitalismo di sorveglianza (per dirla con le parole della studiosa Shoshana Zuboff) in cui l’esperienza umana viene trasformata in materia prima per prodotti predittivi. I tuoi dati non servono solo a te (per migliorare il servizio), ma diventano merce da cui estrarre valore – vendendoli ad altri o usandoli per manipolare il tuo comportamento.
Nel caso di Temu e Shein, l’enorme mole di dati raccolti viene usata anche per plasmare l’offerta commerciale in tempo reale. Shein, ad esempio, produce nuovi capi in base ai trend captati quasi istantaneamente dal comportamento di milioni di utenti: tu clicchi su una maglietta con stampa floreale, e poche settimane dopo eccone una simile in vendita. Sei diventato cavia inconsapevole di un laboratorio industriale globale. Temu spinge questo concetto ancora oltre, integrando i dati del tuo shopping con i dati provenienti da ogni angolo del tuo smartphone, per poi rivenderli o impiegarli in altri contesti (pubblicità mirata, credit scoring, chissà cos’altro).
Il rischio qui è duplice: da un lato perdiamo gradualmente la libertà di scelta autentica, perché ogni nostra decisione è sempre più indirizzata e condizionata dall’algoritmo che sa come solleticare i nostri desideri. Dall’altro si delinea una società “orwelliana” privatizzata, dove poche grandi piattaforme detengono un potere di monitoraggio e influenza di massa che un tempo spettava solo agli Stati totalitari. Siamo sempre meno cittadini sovrani e sempre più oggetti di analisi e bersagli di persuasione. Quando il marketing diventa così fine da sembrare invisibile, la democrazia stessa ne risente, perché l’opinione pubblica e i comportamenti collettivi possono essere plasmati da chi possiede questi dati. È uno scenario limite, certo, ma non più così improbabile se consideriamo la scala globale di Temu, TikTok, Shein e compagnia e la fame insaziabile di dati che le contraddistingue.
Minori online: eludere i divieti è un gioco da ragazzi
In questo panorama già fosco, una fetta di utenti è particolarmente vulnerabile: i minori. Ci si aspetterebbe che bambini e adolescenti siano almeno in parte protetti da certi eccessi del mondo digitale – ad esempio tramite limiti di età per l’accesso a piattaforme di e-commerce o social media. Ma la realtà è che i giovanissimi riescono spesso ad aggirare con facilità le restrizioni anagrafiche online. Un recente report sulla verifica dell’età ha evidenziato un dato sorprendente: quasi un tentativo di registrazione su quattro sui siti vietati ai minori è in realtà effettuato da un under 18 che cerca di mascherare la propria età. Le strategie usate dai ragazzi per infiltrarsi nei mondi digitali “per adulti” rivelano anche una certa preoccupante creatività tecnologica.
Documenti d’identità prestati o falsificati: nel 38% dei casi i minorenni usano la carta d’identità di un fratello maggiore o un genitore, oppure acquistano scan/credenziali falsificate sul web. Molti sistemi di verifica blandi si limitano infatti a chiedere l’upload di un documento, senza controlli di corrispondenza facciale.
VPN e strumenti di anonimizzazione: il 33% aggira i filtri geografici o di rete usando VPN, proxy e software di spoofing. Ad esempio, impostano una VPN su un paese dove la piattaforma non è obbligata per legge a chiedere la verifica dell’età, oppure mascherano l’indirizzo IP per sembrare un utente adulto.
Selfie “deepfake” o IA ritoccate: ed ecco la frontiera più inquietante, usata nell’11% dei tentativi. Ci sono app e tool di intelligenza artificiale capaci di generare selfie ultra-realistici di volti più maturi, o di modificare la propria foto facendola sembrare di una persona adulta. Questi vengono poi usati per superare controlli biometrici automatici che confrontano il viso dell’utente con il documento: se l’IA è abbastanza brava, il sistema viene ingannato.
Insomma, per molti adolescenti l’età è solo un numero da manipolare a piacimento online. Ciò significa che ragazzi di 13-16 anni possono tranquillamente ritrovarsi su Temu, su piattaforme di shopping o social teoricamente vietate ai minori, senza che nessuno lo sappia. E questo li espone in pieno a tutti i rischi di cui sopra – dalla sorveglianza alla manipolazione commerciale, se non peggio – in un’età in cui non hanno gli strumenti critici per difendersi.
Dipendenza precoce: shopping compulsivo e ansie tra i giovani
Proprio i minori rappresentano la fascia d’età più fragile di fronte ai meccanismi persuasivi di app come Temu. Il loro cervello è ancora in formazione: le aree prefrontali deputate al controllo degli impulsi e alla valutazione delle conseguenze a lungo termine non sono pienamente mature nell’adolescente. Questo li rende particolarmente suscettibili allo shopping compulsivo online e alle dipendenze comportamentali in genere. I dati allarmanti non mancano: si stima che già il 16% degli studenti mostri comportamenti riconducibili a una dipendenza da acquisti online. In altre parole, quasi un ragazzo su sei sviluppa sin da giovane un rapporto patologico con lo shopping sul web, sentendo un bisogno irrefrenabile di comprare oggetti di cui spesso non ha davvero necessità.
Questa vulnerabilità si riflette anche sul piano finanziario: secondo sondaggi su campioni di adolescenti, il 15,8% dei giovani spende tra l’81% e il 100% delle proprie entrate mensili (paghette, piccoli lavori, ecc.) in acquisti sul web. Praticamente azzerando tutto quel che hanno per comprare online. Questo indica una difficoltà diffusa nel distinguere tra bisogni reali e desideri indotti: tanti minorenni faticano a resistere al canto delle sirene del commercio digitale, complici le continue offerte, notifiche e pubblicità cucite su misura per loro. Il rischio è l’adozione precoce di stili di vita iper-consumistici, dove l’identità personale viene definita più da ciò che si possiede che da ciò che si è.
Le conseguenze psicologiche di queste dinamiche, quando l’esposizione inizia così presto, possono essere serie. La costante pressione consumistica e comparativa a cui i giovani sono sottoposti è correlata a incrementi di ansia e depressione in età scolare. L’adolescente vede online coetanei (o influencer poco più grandi) sfoggiare continuamente nuovi acquisti e felicità apparente; il confronto per l’adolescente può essere schiacciante. Se “gli altri hanno quel capo alla moda e io no” scatta il senso di inadeguatezza, alimentato dagli algoritmi che enfatizzano proprio quei contenuti per tenerlo agganciato. Ne risente l’autostima: ci si sente perennemente non all’altezza se non si riesce a stare al passo con i trend consumistici.
Col tempo, questo meccanismo può minare l’equilibrio emotivo del giovane. Si instaurano circoli viziosi di gratificazione e crollo: l’acquisto impulsivo regala uno high momentaneo (yay, pacco in arrivo!), seguito magari da senso di colpa o delusione (l’oggetto non riempie davvero il vuoto emotivo). Questi sbalzi possono contribuire a veri e propri disturbi dell’umore. Inoltre, abituarsi a regolare le proprie emozioni tramite l’atto dell’acquisto o la navigazione compulsiva su Temu/Shein può compromettere la capacità di gestire i propri stati d’animo in modo sano. Invece di imparare a tollerare la noia, la tristezza o l’ansia, si cerca una fuga immediata nello stimolo digitale e nell’acquisto compulsivo. È così che l’educazione emotiva viene, in un certo senso, delegata alle app, con esiti deleteri sulla crescita dei ragazzi.
Temu messa a confronto gli altri colossi: perché è la più pericolosa
A questo punto qualcuno potrebbe obiettare: “D’accordo, Temu è invadente, ma in fondo non fa nulla di troppo diverso da Amazon o da altri giganti. Ci spia per venderci cose, dov’è la novità?” La tentazione di liquidarla come un “Amazon un po’ più aggressivo” è forte, ma sarebbe un errore sottovalutarla. In realtà Temu rappresenta un salto di qualità (in peggio) rispetto alle piattaforme che già conosciamo, proprio perché combina e supera i modelli di business esistenti. Vediamo il confronto:
Amazon: Il colosso di Bezos osserva ogni tuo click sul carrello e sulle ricerche, ma lo fa con uno scopo relativamente lineare: farti comprare di più, più in fretta. Il suo modello è ossessivamente orientato al cliente e all’efficienza. Certo, Amazon colleziona montagne di dati sui tuoi acquisti, tuttavia l’obiettivo finale è venderti più prodotti. Ci riduce ad “algoritmi di consumo”, vero, ma il patto è chiaro: tu fornisci i tuoi dati sugli acquisti, loro ti propongono altri acquisti.
Meta/Google: Qui il gioco cambia. Facebook, Instagram, YouTube non ti vendono direttamente un prodotto fisico; il prodotto sei tu. Queste piattaforme ti profilano per vendere la tua attenzione agli inserzionisti. Ogni like, ogni scroll, ogni secondo di visione è monetizzato sotto forma di pubblicità mirata. Non sei cliente, sei bersaglio. Il tuo comportamento viene manipolato per farti restare il più a lungo possibile online, così da mostrarti più annunci. Però, anche qui, c’è una sorta di “reciprocità implicita”: tu ottieni un servizio gratuito (i social network, i motori di ricerca, i video) in cambio di spot mirati e perdita di privacy. Siamo target pubblicitari, nulla di più, nulla di meno.
Shein: Il gigante dell’ultra-fast fashion ha ancora un altro approccio. Trasforma gli utenti in cavie di un laboratorio stilistico-industriale. Ogni preferenza espressa sulla app di Shein – un filtro di ricerca, un articolo aggiunto alla wishlist, il tempo speso su certe foto – viene utilizzata non tanto per mostrarti pubblicità, ma per decidere cosa produrre e in che quantità. Shein sforna nuovi vestiti a ritmi folli basandosi sui trend captati in tempo reale dalla sua utenza. In pratica i consumatori sono tester inconsapevoli: le loro scelte determinano la creazione stessa dei prodotti che saranno venduti nelle settimane successive. È un meccanismo circolare: tu clicchi su un vestito, Shein capisce che quel design attira, lo produce in massa e te lo propone a prezzo stracciato poco dopo. Innovativo ma inquietante nel modo in cui sfrutta i consumatori come input del processo produttivo.
Temu, invece, porta all’estremo i modelli degli altri colossi: vende prodotti come Amazon, monetizza i dati come Meta, sfrutta le preferenze come Shein. Ma non si ferma lì: combina e amplifica tutti questi approcci, trasformando lo smartphone in un osservatorio continuo. È questo salto di scala che rende Temu più inquietante delle piattaforme che già conosciamo e consideriamo invasive. L’utente, in questo schema, non è più né cliente, né target pubblicitario, né tester: è pura materia prima statistica, un fornitore vivente di dati a 360 gradi da cui estrarre valore in ogni modo possibile. Il tuo essere digitale e fisico viene assimilato nella macchina di Temu. Temu vuole conoscere ogni tuo respiro digitale e usarlo. È un’ambizione di controllo che supera la semplice finalità commerciale dichiarata.
Dati e libertà: la posta in gioco
Il filo rosso è evidente: nessuna di queste piattaforme può vivere senza attingere ai nostri dati personali. Ma mentre la maggior parte – per quanto invadenti – cerca “soltanto” di piegare quei dati a scopi commerciali relativamente circoscritti, Temu sembra interessata a possederli tutti, a qualsiasi costo. La differenza non è solo quantitativa, è qualitativa. Siamo passati dal monitorare ciò che compriamo online al monitorare tutto: dagli acquisti agli spostamenti, dalle app installate, ai messaggi privati. Ogni aspetto della vita digitale (e indirettamente di quella reale) dell’utente diventa materiale grezzo da estrarre e monetizzare.
Non si tratta più della semplice invasione della privacy cui forse, obtorto collo, ci eravamo quasi abituati. Qui si profila la cancellazione della linea di confine tra commercio, sorveglianza e controllo. Temu, in un certo senso, incarna la realizzazione più pura (e perturbante) del capitalismo della sorveglianza: un modello in cui ogni dispositivo è un sensore, ogni azione un dato, ogni dato un potere. Come nei tuoi peggiori incubi.
Fino a che punto siamo disposti a spingerci, quanto di noi siamo pronti a cedere sull’altare della convenienza e degli sconti. Perché con Temu non stiamo barattando solo un po’ di informazioni per qualche prodotto economico; stiamo rischiando di cedere il controllo totale sulle nostre vite digitali. E quando il digitale pervade ogni aspetto del reale, perdere il controllo lì significa perderlo in assoluto.
È una scelta di civiltà: si tratta di accettare passivamente un esperimento globale in cui gli individui sono solo fornitori di dati – oppure pretendere regole e limiti che ristabiliscano un equilibrio di potere tra cittadini e piattaforme. Facciamo dunque attenzione: la prossima volta che un’app “gratuita” promette miracoli, ricordiamoci che se non paghi per il prodotto, il prodotto potresti essere tu – anzi, nel caso di Temu, il prodotto sono i tuoi dati, e il prezzo in ballo è la tua libertà.
Fonti
ASPI – Australian Strategic Policy Institute, Mapping China’s Technology Giants, 2021, https://www.aspi.org.au/report/mapping-chinas-tech-giants
Grizzly Research, Shein: China’s Secretly Grown Fast Fashion Giant Could Be Worth Billions Less Than Investors Think, marzo 2023 (sezione dedicata a Temu/PDD), https://grizzlyreports.com
Google, Google removes Pinduoduo from Play Store over malware concerns, Reuters, 21 marzo 2023, https://www.reuters.com/technology/google-removes-chinese-app-pinduoduo-from-play-store-2023-03-21/
US Court Documents, Class Action Complaint against Temu (PDD Holdings Inc.), dicembre 2023, United States District Court, consultabile su Justia: https://dockets.justia.com/
Zuboff, S., The Age of Surveillance Capitalism, PublicAffairs, 2019
PDD Holdings, Annual Report 2022, documento ufficiale depositato alla SEC, https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=0001737806
ANSA, Temu sotto accusa negli Stati Uniti: “raccolta dati ingannevole”, 29 dicembre 2023